Intervista: Fabrizio Saiu e la risonanza dello spazio
 |
Fabrizio Saiu è un artista a tutto tondo che, partito dallo studio della batteria, è gradualmente arrivato
all'arte performativa attraverso una ricerca continua volta alla sperimentazione totale.
Ecco l'intervista.
Immagina
di avere davanti a te un bambino, spiegagli di cosa ti occupi.
Mi occupo di tante cose. Leggo, scrivo, suono e
insegno musica, fotografo, faccio dei video, quando posso seguo concerti,
ascolto musica e visito le mostre. Tutte queste attività costituiscono una
parte fondamentale della mia vita. Da qualche anno sono interessato ai legami
tra musica e altre attività come scrivere, ascoltare, spostare oggetti,
correre, cadere o stare fermi, parlare, cantare e passeggiare. In 22 days here, una sound-performance che
ho realizzato nel 2012, si possono sentire i suoni prodotti da tantissime azioni
differenti, compiute in solitudine o in gruppo: avevo programmato ogni singola
registrazione e in base all’ora, al giorno e al luogo scelti, accendevo il
registratore, che portavo sempre con me, e registravo quanto accadeva. Per
alcuni giorni avevo deciso anche quale tipo di azione dovevo compiere durante
la registrazione: la ricerca di un testo inesistente o l’ascolto di una
conferenza di filosofia. É stato un modo per fare un omaggio a John Cage per il
centenario dalla sua nascita. É stato divertente.
La
tua carriera artistica è cominciata quando hai scoperto la batteria…
È accaduto dopo. Se invece ti riferisci alla
passione per la musica, questa è nata intorno agli anni 95/96 quando da bambino
seguivo mio padre nei suoi concerti fino a quando non ho incanalato questa
passione nello studio della batteria, intorno al 99. Seguire mio padre fu
certamente un insegnamento grandissimo, ero piccolo e vivevo quelle serate di
musica nel modo più avvincente possibile. Stavo sempre attaccato ai fonici e a
tutti i musicisti del gruppo, soprattutto al batterista che assistevo
meticolosamente nel montaggio e nella microfonazione della batteria e durante
il soundcheck. Poi arrivava il concerto e lì assistevo con grande attenzione e
partecipazione. Il mio primo insegnante è stato Emanuele Murroni, un percussionista di formazione classica molto
attento anche alla musica pop e latina, al jazz e alla fusion e mi ha trasmesso
l’attenzione per le caratteristiche timbriche del suono e per l’improvvisazione
musicale. Parallelamente ai suoi insegnamenti suonavo con mio padre in trio. Fu
anche quello un periodo di grande formazione, una sorta di laboratorio di
composizione e improvvisazione rock-jazz. Il primo vero lavoro è arrivato nel 2006
quando ho collaborato all’incisione del primo disco di Francesco Saiu e Pietro Ballestrero con Achille Succi al clarinetto
basso e Aya Shimura al violoncello; ho iniziato poi a lavorare come concertista
e come insegnante a tempo pieno.
 A
un certo punto però la batteria non era più sufficiente e hai iniziato a
cercare “rumori” (correggimi se sbaglio), per ampliare la gamma di suoni
utilizzabili..
A
un certo punto però la batteria non era più sufficiente e hai iniziato a
cercare “rumori” (correggimi se sbaglio), per ampliare la gamma di suoni
utilizzabili..
Gradualmente mi avvicinai al jazz, anche sotto
l’influenza di mio fratello a cui devo molto, e iniziai così la mia
frequentazione dei seminari estivi di Nuoro Jazz e Sant’anna Arresi Jazz, dove
incontrai musicisti che suonavano la batteria utilizzando dei metalli disposti
sui tamburi, piatti forati o parzialmente tagliati per ottenere suoni
particolari. Tra questi, Andrea Ruggeri
fu un esempio chiaro e lampante. Cominciai anche io a lavorare sul suono in
quei modi. Nel 2004, l’incontro con Roberto
Dani mi traghettò, in maniera direi definitiva, verso una sconvolgente
concezione del suono, basata non sulla mera modificazione degli strumenti del
set mediante sovrapposizioni di oggetti, o veri e propri interventi sulla loro
materia fisica, bensì attraverso una profonda attenzione al movimento del corpo, alla gestualità corporea, e alle
modalità di contatto tra il corpo e lo strumento, coniugata con una concezione del suono come processo
compositivo/improvvisativo in costante movimento. Questa visione
assolutamente sconosciuta alla didattica della batteria, di stampo
prevalentemente americano, se adottata è capace di smontare l’intera concezione
dello strumento e insieme l’intera concezione del suono e del fare musica, in
solo come in gruppo. Ciò significa far saltare in aria la batteria per starci
dentro in un altro modo o sacrificarla definitivamente; in questo modo ebbe
inizio la mia ricerca –maniacale- sulla struttura dello strumento e, dopo molti
tentativi (alcuni buoni altri meno), la sua/mia graduale sacrificazione.
Il
tuo percorso ti ha portato a diventare un artista performativo a tutto tondo,
in cui la musica è sì presente, ma non è più l’unico strumento che utilizzi per
esprimerti (il concerto classico con chitarra, basso, batteria per intenderci,
non è ciò di cui ti occupi oggi)
Sì, era in qualche modo inevitabile. Era quanto
potevo fare, né più né meno.
In questo senso oggi ho quasi completamente abbandonato
l’idea di tornare a suonare la batteria in un gruppo o in solo. Ci ho provato,
anche con piacere, ma le cose non sono andate avanti. É una strada che mi appartiene, ma che non percorro più nello stesso
modo, mentre l’’insegnamento della batteria mi appassiona moltissimo.
Insegno a suonare la batteria ma contemporaneamente cerco costantemente altro; davanti
alla batteria vedo altro. Proprio questo “altro”, che è già nella batteria,
diviene materia fertilissima per la didattica, per la relazione con gli
allievi, e stabilisce molteplici connessioni con altre pratiche (di qualsiasi
genere, non solo artistiche).
Il
tuo primo progetto in questo senso?
Nel 2010 con Objet sans corps, realizzato in
collaborazione con Paolo Asaro,
fissavo il primo passo disperato e liberatorio verso una concezione del suono
assoggettata al movimento, provocato a sua volta dallo spazio nel quale agivo
(e che, a rigore di concetto, mi agiva).
C’era in questo tentativo, in questo salto, tutto un discorso del negativo, una
dialettica della sottrazione che operava all’interno del processo di produzione
del suono, una riduzione ai minimi termini dei fattori che concorrono alla
generazione del suono: il corpo, lo spazio e alcune materie (una lastra, due
martelli, due spatole, due stecche di acciaio, una cazzuola). Il
suono, risonanza dello spazio, non era più inteso come suono dell’oggetto,
dello strumento, ma dello spazio per l’appunto che era in qualche modo
una dimensione totalizzante non divisibile in parti, in perenne movimento e collisione
con se stesso, una centrifuga.
Child of Tree, me ne vuoi parlare?
Child
of Tree
è una composizione di John Cage del
75 che intreccia l’alea all’improvvisazione e si concentra su tre concetti
fondamentali: struttura, durata, e strumento. Non posso entrare nel dettaglio
di come queste tre dimensioni siano trattate dal compositore, ma posso dire che
è su queste che ho lavorato, in modo critico, per la performance Getting Through “Child of Tree”,
letteralmente Attraversando Child of
Tree. Il risultato è una performance
collettiva basata sulla relazione (a un tempo contatto e distanza) tra la
pratica di lancio del frisbee e la pratica rituale della processione, intese
come due modalità di vivere e agire lo spazio, ma anche come due modalità di
confrontarsi con la meta, col punto di arrivo, con la fine di un percorso.
GTCOT può essere performata in qualsiasi spazio organizzato in un percorso avente
un inizio e una meta. Nella fase iniziale il percorso ha un carattere
“pedagogico” – in questa illustro alle persone come suonare i piatti durante la
processione, come lanciare il frisbee, come registrare e filmare, una sorta d’introduzione
alla struttura normativa di ogni pratica. Nella meta invece l’azione è
completamente indeterminata e basata sulle caratteristiche del luogo. Può
accadere di tutto, un happening, un concerto, una partita, una chiacchierata o tutto
questo assieme. Durante il percorso le diverse pratiche si sovrappongono fra
loro e si disattivano reciprocamente provocando il performativo. Di fatto non si fa né una processione né una partita
a frisbee né una documentazione della performance. Accade il performativo che non è la performance e
neanche la performing art. É un lavoro basato sul rapporto tra differenti campi normativi e sulla loro reciproca
dis-attivazione.
 |
| Still Métron |
Immagina
di avere davanti a te a Jean Paul Sartre (o qualche altro pensatore se
preferisci), spiegagli di cosa ti occupi.
Mi metti in una difficile situazione. Posso dirti
che attualmente sto trovando interessante lavorare attorno alla definizione che
Giorgio Agamben propone della Klēsis
messianica paolina; essenza della vocazione messianica (Klēsis) è la modalità
del come
non «piangenti come non piangenti» che non va intesa,
scrive Agamben, con «piangenti come ridenti», ovvero la vocazione non
va né verso un altrove né si esaurisce nell’indifferenza di due opposti. É in
qualche modo ciò che accade nelle tre pratiche di GTCOT, che proprio nella loro
disattivazione sono attivate divenendo così performative piuttosto che
performanti. In un certo senso l’Hōs me (il come
non) paolino è la modalità del restare nell’atto, non una funzionalità
dell’atto, non un muovervi verso, ma un modo di restare, una trasformazione che
non implica l’abbandono di qualcosa o di qualcuno, bensì un movimento che è una
permanenza. É in questo contesto che si ha l’attivazione dell’atto mediante la
sua disattivazione. Nessun processionante smette di essere processionante, come
nessun giocatore smette di essere giocatore. Tuttavia sia l’uno che l’altro
stanno nella pratica in una modalità performativa, ovvero la compiono in una
sospensione. É su questa concezione del performativo, coniugata al pensiero
delle pratiche di Carlo Sini, che
tratta il concetto di pratica come intreccio complesso di scritture, che sto
articolando l’attuale percorso di ricerca.
Dove
possiamo vederti all’opera?
Sicuramente sul web, sia su fabriziosaiu.com che
su aboutobjetpetita.tumblr.com, e ovviamente sui miei canali Vimeo e Youtube.
Proprio di recente ho caricato il teaser di Métron, performance realizzata il
10 Maggio con Paolo Pãx Calzavara presso la A+B Gallery, a Brescia. Si tratta
del mio/nostro ultimissimo progetto.
Progetti
futuri?
Sto lavorando sui video di Getting Through “Child
of Tree”. In questi giorni sto ricevendo i materiali documentati dai
partecipanti alle performance. Ho intenzione di fare un video sul performativo basandomi su alcune
categorie concettuali sulle quali ho elaborato la performance: durata,
inquadratura, meta, etc...
Il 23 luglio farò una performance, in
collaborazione con gli artisti Francesco Fonassi e Tonylight, per il Musical
Zoo Festival presso il Castello di Brescia. L’azione è stata commissionata da
due importanti realtà legate all’arte contemporanea, il Linkartcenter e la A+B.
Vi consiglio di cercarle sul web. Stanno facendo, in modi differenti ma con il
medesimo spirito e passione, un lavoro molto importante sia sotto il profilo
della ricerca artistica che su
quello della diffusione del lavoro di giovani artisti. Ci sono poi alcune collaborazioni con
il teatro e con la danza e un nuovo lavoro in solo sul quale per il momento
terrò il segreto.
 |
| Foto di Alessandro Ligato |



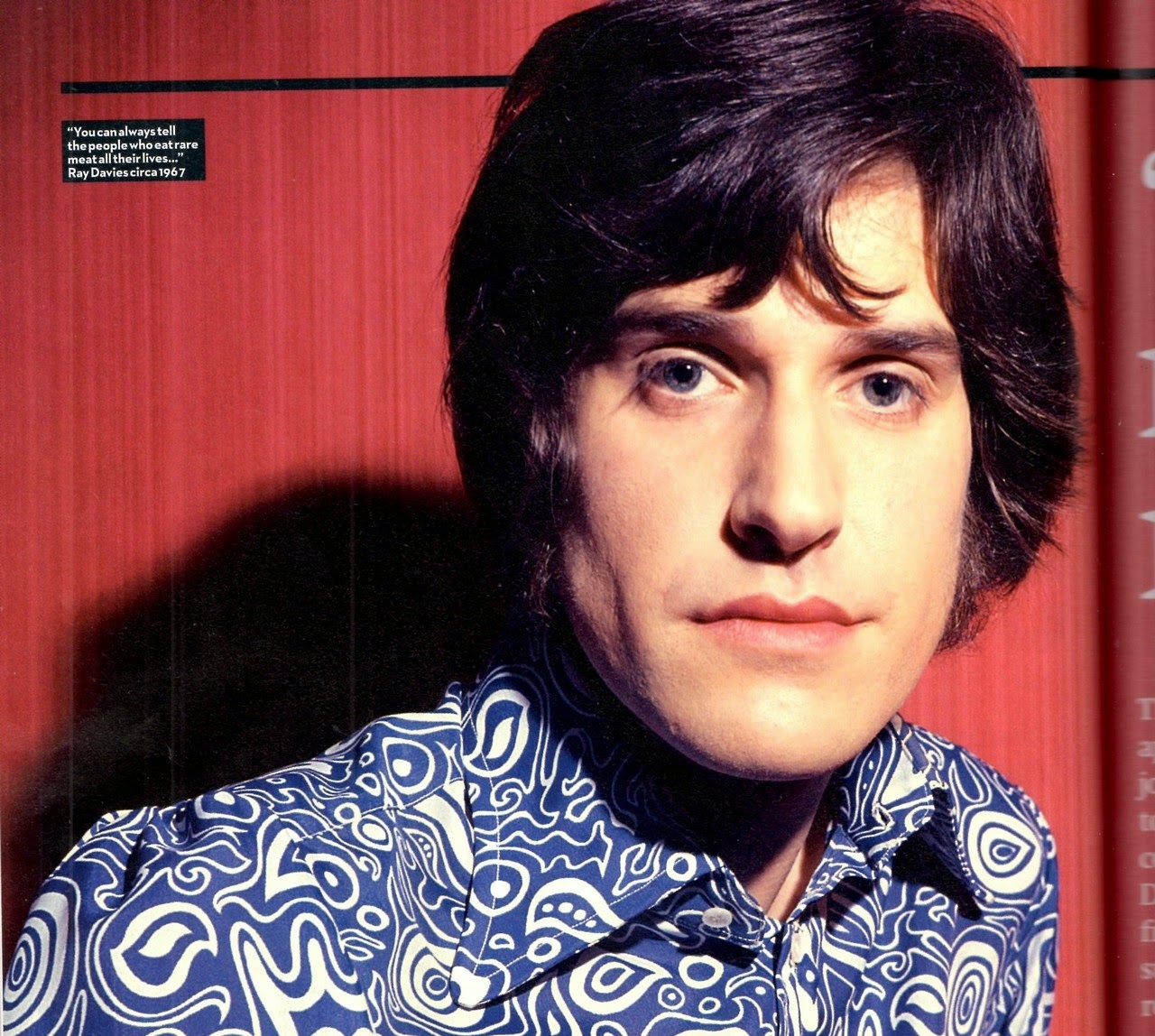
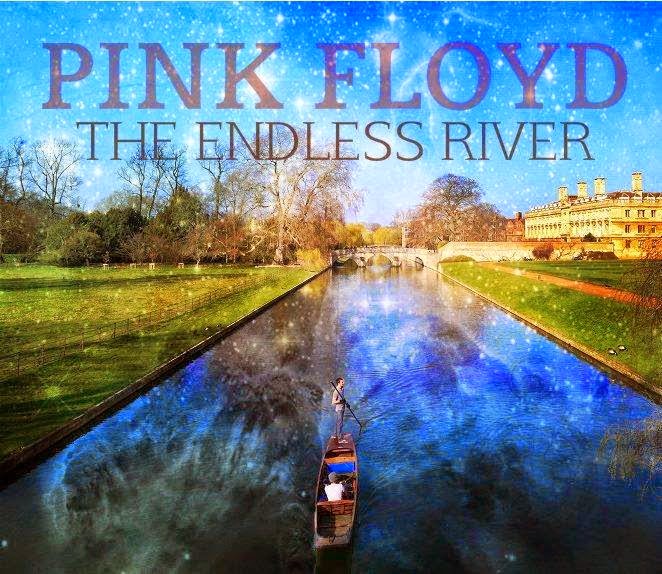




Commenti